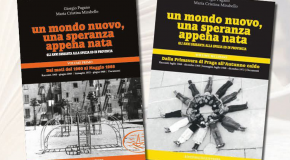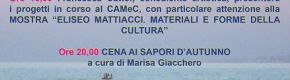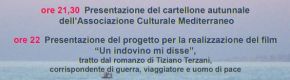Dino Grassi, “Io sono un operaio. Memorie di un maestro d’ascia diventato sindacalista”, a cura di Giorgio Pagano recensione di Mariagrazia Meriggi
Dino Grassi, “Io sono un operaio. Memorie di un maestro d’ascia diventato sindacalista”
a cura di Giorgio Pagano
RECENSIONE DI MARIAGRAZIA MERIGGI
Rivista storica del socialismo maggio 2024
Spesso mi è capitato di scrivere che in Italia mancano dizionari biografici come l’inglese J. Saville e J.Bellamy o l’autentico monumento di erudizione e metodo del Maitron, ma la storiografia italiana conta su studiosi che hanno ormai consolidato una ricca tradizione nel campo della storia orale ben consapevole che l’intreccio fra biografie, autobiografie, memorie delinea la prosopografia di più generazioni di lavoratori e militanti. Questo bel volume ne fa certamente parte sia in quanto documento sia in quanto analisi e interpretazione: ne indicheremo gli aspetti essenziali invitando i lettori a immergersi nel sobrio fascino del racconto. Come ricorda il curatore, nel dicembre 1994 Giovanna Nevoli, della segreteria della Camera del Lavoro di La Spezia, chiese a Dino Grassi e ad altri dirigenti o ex dirigenti sindacali un intervento per una «raccolta di testimonianze» utili a costituire il «proprio Archivio storico».
Fra le varie possibilità Dino Grassi scelse un testo libero, che scrisse nel corso del ’95 e che, per diverse vicende, viene pubblicato solo adesso. Il ’95 era ancora vicino cronologicamente alle sconfitte e rotture che avevano travolto il mondo sociale e antropologico di Dino Grassi e del suo tipo di classe operaia, sulle cui caratteristiche torna con grande libertà e molte contraddizioni nella conversazione del 2023 con il curatore. I suoi caratteri pongono a noi lettori e lettrici, storici e storiche dei mondi del lavoro e delle loro culture domande cui probabilmente non daremo mai risposte esaustive. Dino Grassi è un operaio altamente qualificato (un “maestro d’ascia”) dei cantieri navali di Muggiano, esponente dunque della comunità operaia di La Spezia, che molte testimonianze ricordano come particolarmente ispirata a un’etica militante improntata a una sobrietà intransigente nella vita quotidiana, severissima nell’obbligo – a suo dire non abbastanza codificato – di cedere al partito gran parte della retribuzione delle cariche istituzionali. Un’austerità che non impedisce il gusto per “lussi” culturali, come le lezioni di violino. Notiamo fra le caratteristiche di questo militante altri aspetti che confermano storie già note. Il padre era comunista ma come molte famiglie dello stesso tipo anche la sua cercò di evitare problemi ai figli, consentendo loro di acclimatarsi in una specie di consenso al patriottismo fascista.
Ma il ’43 e soprattutto il primo sciopero del ’44 segnano un ingresso nella vita vigile e consapevole con cui si ricollega alla storia famigliare. Antifascista, non partecipa però alla lotta armata affermando – con una osservazione molto fine – che il suo coraggio era di quelli che si manifestano nel lungo periodo, sfidando le frequenti minacce di perdere il lavoro, come eletto di Commissione interna. Ma ciò che colpisce particolarmente è la vera e propria passione per il lavoro ben fatto proprio in nome del quale lottare contro tempi troppo lunghi, fatica eccessiva, condizioni insalubri e naturalmente bassi salari: tutte condizioni di sfruttamento che avviliscono il lavoratore ma anche il lavoro. Il nostro protagonista è stato convintamente comunista ma unitario – coi socialisti e coi cattolici – in nome della condivisione della condizione sociale. La fierezza dell’essere un bravo operaio che dà l’esempio e può permettersi quindi di rivendicare faceva parte della retorica del PCI, ma in questo caso Grassi sottolinea l’identità operaia come prevalente. Negli anni Sessanta, in cui ricade buona parte della sua attività soprattutto nelle grandi fabbriche meccanizzate, sono protagonisti delle lotte, come è ben noto, giovani operai di recente immigrazione con alle spalle il lavoro agricolo o i “mille mestieri” delle città del Sud. È altrettanto noto che non fu semplice far dialogare e cooperare forme così diverse di identità e costruire le espressioni adeguate a una nuova composizione di classe. I caratteri di questa “nuova” classe operaia si spiegano con la razionalizzazione fordista e con la mancanza di una precedente socializzazione industriale ma le sue forme e i rapporti molto diversi con operai professionali, capi, tecnici e impiegati restano temi ancora da indagare, anche se recenti ricerche hanno cominciato a studiare anche le periferie di questi conflitti. L’intervista ci consegna interamente la problematicità di questi rapporti anche quando evoca gli incontri prima con gli studenti nel ’68-’69 poi con i gruppi politici, che sono rifiutati per il (presunto?) settarismo, ma molte delle cui critiche emergono autonomamente. Egualitarismo, democrazia nell’organizzazione, politicità implicita nei conflitti del lavoro sono rivendicati da Grassi come caratteristiche di quella classe operaia che gli aveva insegnato tutto. «Nella testimonianza per il libro Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta a La Spezia
ed in provincia, tu dici una frase significativa: “Gli operai erano più avanti”». «È così. I dirigenti avevano paura perché non avevano il polso. Non capivano che gli operai non ce la facevano più». (p 153). E su Lama: «Una volta Luciano Lama disse: “Non vogliamo diventare il sindacato dei manovali”. Fu una frase infelice» (p. 154).
Come suggerisce il curatore (p. 165), sulla scorta di Edward P. Thompson, gli operai come Dino Grassi sono diventati classe in un intreccio di oggettività economica e scelte culturali. In nome di questa adesione profonda ai bisogni sociali Grassi ci consegna anche la speranza della irriducibile presenza almeno delle possibilità del conflitto.
Mariagrazia Meriggi
Popularity: 1%