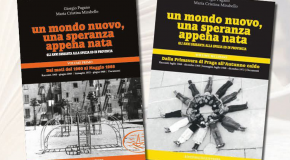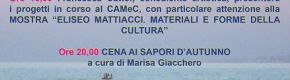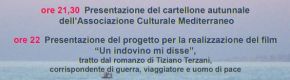L’addio a Francesco Vaccarone. Ricordi e riflessioni sull’arte, la vita, la politica – Prima parte
Città della Spezia, 28 aprile 2024
I funerali di Francesco Vaccarone, tenutisi ieri nella chiesa di Santa Maria, mi hanno suscitato un turbinio di ricordi e di riflessioni.
Innanzitutto sugli anni Sessanta e il Sessantotto: perché fu in quella fase storica che Vaccarone si formò e diede un contributo importante al rinnovamento della vita culturale e artistica della città, oltre a sviluppare una personale creatività che è riemersa nei momenti più felici del suo percorso successivo. Ho studiato quella fase per il libro “Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia” e ho cominciato a viverla, quattordicenne, nel 1968. Vaccarone definiva la situazione spezzina, già nel dicembre 1965 in un articolo su “Il Lavoro”, come contrassegnata dal “fermento culturale”:
“Da alcuni mesi si assiste alla Spezia a un risveglio di attività culturali, per volontà di alcuni gruppi di giovani che, a diversi livelli di impegno e di interessi, sono riusciti a creare nella città nuove possibilità di discussione intorno ai più disparati problemi, dall’arte all’economia, dal costume alla scienza. Sono nati circoli culturali, gruppi teatrali, gruppi studio d’arte figurativa, un attivo Sindacato dei pittori e degli scultori, e nuovi altri circoli e gruppi si stanno costituendo”.
Vaccarone aveva allora solo 25 anni. Ma si era già distinto: nel 1959 – a 19 anni – era stato selezionato per una mostra alla galleria Adel. E nel 1961 aveva fondato, con altri suoi coetanei, il Gruppo Giovanile Culturale Lionello Venturi, sotto l’ala protettrice di un “vecchio”, forse il più grande di tutti: Gino Bellani.
Nell’anno dell’articolo su “Il Lavoro”, il 1965, Franco – così l’ho sempre chiamato – partecipò attivamente alla discussione critica sul Premio del Golfo, una mostra nazionale di grande prestigio che era da tempo in crisi: chiuse proprio con l’edizione del 1965, per riaprire solamente nel 2000 (purtroppo per pochi anni).
Era un giovane intelligente e colto – laureato in Filosofia a Pisa, per qualche anno fece l’insegnante –, geniale e “irrequieto”. “Giovane irrequieto” lo definì un critico de “L’Unità”, scrivendo nel 1962 su una mostra del Circolo Venturi. L’articolo era significativamente intitolato “Successo decretato per i ‘giovani leoni’”.
Nel 1965 Franco, “giovane leone”, partecipò alla VI Biennale di San Benedetto del Tronto con un’opera assai provocatoria, che generò molte polemiche, intitolata “Omaggio a Dante”: Papa Pacelli era rappresentato all’inferno, tra gli ignavi, come Celestino V nella “Divina Commedia” di Dante. In una parte del dipinto, in cui ondeggiava una grande folla tra cui il re e il duce, vi era un collage con la foto di una fila di ebrei che entravano ignari in una camera a gas in un campo di sterminio nazista.
Il 1965-1966 furono anni chiave per Franco e per la città , che prepararono il Sessantotto.
Nel 1965 si tenne, in via Colombo, la Seconda Rassegna spezzina di arti figurative, voluta dal Circolo “I Corsari” guidato da Franco Carozza: una mostra davvero rappresentativa dei pittori e scultori spezzini dell’epoca. Insieme ai “vecchi” c’erano molti giovani, tra cui Vaccarone. Significativi dei tempi nuovi erano i titoli delle sue opere: “Tempo presente”, “Congo 64”, “Inizio di sciopero”.
Sempre nel 1965 fu inaugurata, in Sala Dante, la Prima Rassegna Sindacale d’Arte: ottantasei artisti con 186 opere delle Sezioni sindacali artisti della CGIL di Carrara, La Spezia, Genova, Savona e Imperia. Quella spezzina, costituitasi sempre in quell’anno, era presieduta dal pittore Ernestino Mezzani; Vaccarone ne fu tra i fondatori. Il loro obiettivo era creare una rete di “gallerie d’arte del sindacato”.
Alla Spezia nacque infatti, nel 1966, “Spezia 66”, in via Manzoni: la galleria d’arte degli artisti della CGIL.
Sulle vicende di quegli anni ecco il ricordo di Gabriella Peroni, già allora moglie di Franco, in “Un mondo nuovo, una speranza appena nata”:
“Ricordo in particolare gli anni 1965-1966: mio marito, già molto attivo come artista e promotore di dibattiti, riviste, convegni (tra cui quello del Gruppo 63 alla Spezia), entrò nel Gruppo Studio di Genova, un vivace collettivo di artisti, critici e intellettuali, animatore della Galleria d’Arte La Carabaga e fondatore della rivista ‘Trerosso’. Gli incontri redazionali si tenevano molto spesso a casa nostra con un via vai di persone che discutevano animatamente sul ruolo dell’arte e degli artisti, sulla società capitalista e i suoi miti, sull’utilizzo dei mass media per il controllo delle masse, sulla famiglia come cinghia di trasmissione di valori reazionari, sulla condizione della donna, sulla libertà sessuale.”
Nel 1966 uscì il “numero 0” della rivista “Arti Visive”, a cura della Federazione Nazionale Artisti della Spezia. Francesco Vaccarone ne era il direttore. Il comitato di redazione era composto da Primo Biagioni, Giuseppe Del Conte, Ernestino Mezzani, Saro Mirabella, Navarrino Navarrini, Manlio Poggetti, Aldo Rescio, Vittorio Sopracase, Francesco Vaccarone, Tullio Vietri e Guido Ziveri. Molte le redazioni periferiche, tra cui quella di Savona, con Stelio Rescio, fratello di Aldo. La redazione Architettura e Urbanistica era composta da Carlo Paladini e Luigi Cocevari Cussar. La redazione Teatro da Fulvio Acanfora, Gianluigi Burrafato, Antonello Pischedda. La redazione Cinema da Carlo Giovannoni, Marco Manciulli, Gabriella Peroni, Giorgio Manfroni. Il coinvolgimento dei giovani intellettuali spezzini fu molto ampio. Tra loro c’erano iscritti al PCI e alla FGCI, come Vaccarone, Rescio, Poggetti, Manciulli, al PSIUP, come Mezzani, al PSI, come Burrafato e Pischedda. E giovani senza partito.
Racconta, nel libro, Piergiorgio Sommovigo, allora giovane intellettuale del PSIUP:
“Negli anni Sessanta trionfava la Pop Art (non a caso il premio della Biennale di Venezia nel 1964 fu vinto, non senza polemiche e probabili interventi dall’alto, si parlò di un ‘diktat”’USA, da Robert Rauschemberg). La Pop Art rappresentò comunque una vera e propria rivoluzione nell’atteggiamento artistico e nella percezione dell’opera d’arte, privata dall’’aura’ che tradizionalmente la circondava, insomma pienamente ‘adeguata’ alla realtà più comune, e in molti casi riproducibile, seriale. Alla Spezia esponente di punta di tale tendenza era Francesco Vaccarone, che si legò al gruppo della Carabaga di Genova (il nome Carabaga, dissacrante, è già di per sé indicativo della rottura con la tradizione). Vaccarone fece una serie di quadri tipo ‘collage’ usando diversi materiali (articoli di giornale, sottovesti femminili) molto sperimentali. Era una tendenza che potremmo definire New Dada. […] I partiti spezzini guardavano con curiosità a questo mondo: il più interessato era sicuramente il PCI, che però non attuò mai una politica specifica di aggregazione in questo campo. Nell’ambito del PCI il più attento, curioso dell’arte, disponibile ad accoglierne le novità era sicuramente Flavio Bertone ‘Walter’”.
Nel libro Paolo Casella, giovane artista e studente alla Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, spiega:
“Vaccarone ha poi saputo gestire molto bene la sua vita, ma allora era ‘il’ giovane dell’arte spezzina, il primo dei giovani”.
Un altro episodio della gioventù di Franco è ricordato da Franco Ferrini:
“Nel 1967 o nel 1968 andammo al Teatro Astra a contestare una piece drammatica di Diego Fabbri. Protagonista era un giovane scapestrato, un partigiano che aveva abbandonato il figlio, che era stato allevato da una famiglia democristiana… Il partigiano “cattivo” rivoleva il figlio. Ero con Francesco Vaccarone, Aldo Rescio, Giuseppe Del Conte detto ‘Peppo’, il cui padre aveva un negozio di gastronomia in corso Cavour. Fu ‘Peppo’ a darci le uova. Nella scena in cui il partigiano si portava via il figlio lanciammo le uova… Intervenne la polizia, non ci fecero nulla perché Vaccarone tirò fuori la tessera da giornalista…”
Vaccarone, intervenendo al convegno del 2016 su “Il Gruppo 63 alla Spezia. 1966-2016”, così rievocò quel periodo:
“In Liguria fondammo il Sindacato Artisti più metafisico della storia, senza datori di lavoro. Il riferimento degli artisti era la Camera del Lavoro, facevamo i manifesti con gli operai. La riunione della redazione della rivista ‘Arti Visive’ era aperta agli operai della CGIL. Avevamo rapporti con gli insegnanti delle materie artistiche, realizzammo due poesie visive con le bambine delle scuole medie… In una riunione regionale del Sindacato Artisti incontrammo Luigi Tola e Guido Ziveri del Gruppo Studio ed iniziò la collaborazione… La rivista ‘Trerosso’ prese il nome dalla via della sede della redazione, in vico Scanzi al numero 3 rosso. Era frequentata anche dai camalli del porto… Una volta venne Luigi Nono, a parlarci de ‘La fabbrica illuminata’, la sua composizione realizzata con i suoni delle macchine della fabbrica Italsider di Cornigliano”.
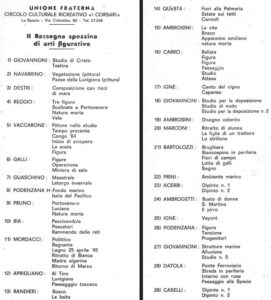
Invito alla Seconda Rassegna di arte spezzina, tenutasi nel 1965 in via Colombo per iniziativa del Circolo “I Corsari”
(archivio Franco Carozza)
Quella storia così ricca finì però molto presto. L’8 dicembre 1967 Vaccarone fu radiato dal Sindacato Artisti della CGIL. Da allora l’arte spezzina fu un intreccio di sperimentazione creativa e di polemiche feroci tra gli artisti. Più in generale fu sconfitto il Sessantotto: quasi subito o dopo pochi anni, in questa sede non importa. Certamente le sue idee di partecipazione e di “rivoluzione umanistica” furono sconfitte.
A quella generazione va in ogni caso riconosciuto il grande merito di avere rinnovato la cultura spezzina. Vaccarone ebbe anche il merito di avere contribuito a rinnovare la cultura del Partito comunista, il partito che, sulla scia del Sessantotto, si apprestava a tornare al governo della città, dove restò a lungo, fino al suo scioglimento. Franco cercò di portare nella cultura del suo partito i nuovi linguaggi, mantenendo forte il legame tra arte e politica, non nel senso di subordinazione della prima alla seconda, ma di rapporto reciproco: arte che ha un impegno civile, politica che grazie all’arte comprende meglio la vita.
I linguaggi cambiano profondamente con il tempo, così i progetti politici: ma resta la necessità della contaminazione. L’arte è vita e discorso sulla vita. La concezione estetizzante dell’arte per l’arte non è di grande utilità all’uomo. Se l’arte parla solo al colto, al dotto, al “borghese”, serve a poco. L’arte deve essere radicalmente “popolare”, cioè voce dei sogni e delle inquietudini umane. In questo modo può dare un contributo decisivo alla politica perché non si separi dalla vita.
Vaccarone cercò – come ognuno di noi, nei diversi ambiti, con le contraddizioni e gli errori inevitabili in chi opera “controvento”, mentre il mondo sta andando in un’altra direzione – di restare fedele a una visione dell’arte che non fosse solo mercato e consumo, ma arte che nasce nel cuore dei popoli e delle persone.
Ne scriverò domenica prossima, nella seconda parte di questo articolo.
Post scriptum:
La fotografia in alto, che ritrae Francesco Vaccarone nel 2011, è di Enrico Amici.
Le due fotografie in basso sono dell’invito della Seconda Rassegna di arte spezzina, tenutasi nel 1965 per iniziativa del Circolo “I Corsari”; provengono dall’archivio di Franco Carozza.
lucidellacitta2011@gmail.com
Popularity: 1%